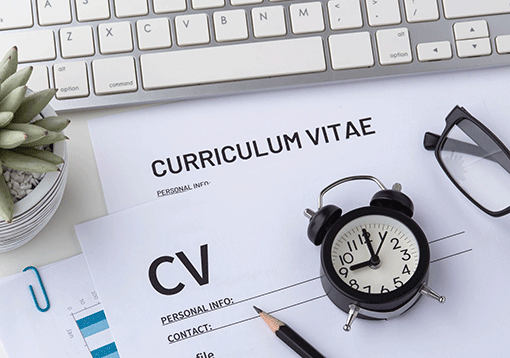Cala la disoccupazione, ma cresce ampiamente il disequilibrio tra domanda e offerta delle competenze. È questo il quadro che si delinea per il mercato del lavoro italiano e l’andamento che si prospetta. «Bisogna guardare al mismatch anche da un punto di vista prettamente numerico», dice Valerie Schena Ehrenberger, Presidente ECSSA (European Confederation of Search and Selection Associations) e Vice-Presidente di Assoconsult. «In generale, non abbiamo abbastanza persone sul mercato, al di là delle specifiche competenze. Questo perché abbiamo una crisi demografica che deve sempre essere presa in considerazione, perché anche se le idee sono tante, se mancano le forze, c’è poco da fare».

Come dobbiamo interpretare i recenti dati sull’aumento del mismatch delle competenze?
«Bisogna andare oltre all’apparenza, che è quella di un disallineamento tra le competenze ricercate e l’offerta del mercato, altrimenti vediamo solo una parte della questione. Un errore che si fa spesso è di passare la palla del problema ad altri: l’azienda che non trova personale tende a dare la colpa allo scarso allineamento del mondo scolastico e accademico rispetto alle competenze richieste dal mercato. Quello che dovremmo fare per interpretare questi dati correttamente è astrarre un attimo e cercare di capire da cosa deriva questo disequilibrio. Solo così ci si accorge che è un fenomeno ben più ampio di quanto non sembri. È certo un problema numerico, per via della crisi demografica. Ma lo è anche di competenze, perché, soprattutto in certi settori, il mondo cambia ben più velocemente della scuola. Abbiamo però anche un mismatch di aspettative, che è veramente forte e su cui raramente puntiamo lo sguardo. Da questo deriva un’attrattività scarsa, più che altrove, per il lavoratore. Non solo come singola azienda, ma anche come sistema socioeconomico e come Paese».
Man mano che le esigenze si evolvono e i datori di lavoro cominciano a faticare a trovare le risorse che cercano, vi sentite chiamati in causa, come consulenti?
«Attualmente vediamo per le nostre società un’enorme crescita della richiesta da parte del mercato. Da tutte le aziende, non soltanto quelle grandi e strutturate che hanno anche del personale molto competente al proprio interno, cui eventualmente possono affiancare un consulente, ma anche l’azienda più piccola. E questo per me è importante da sottolineare, perché il tessuto socioeconomico italiano è fatto dalla PMI, non dall’azienda strutturata. È proprio in questo tipo d’impresa, tipicamente a conduzione familiare, che risiede attualmente la maggiore criticità, soprattutto a livello di comunicazione. È tutto lì il problema: sono due mondi che non si parlano, quello di chi valuta opportunità e quello di chi le può offrire».
Come cambia il ruolo della consulenza in un contesto del genere?
«In generale, come consulenti abbiamo tanto lavoro da fare, ma l’aspetto sostenibile del nostro lavoro in questo momento può essere, al di là di quello da “pompieri” che nella circostanza aiutano a tappare i buchi, quello di spostare sul personale il focus dell’azienda, che spesso era sulla produzione e sulla vendita. Si parla di traction, retention, percorsi di carriera, cultura lavorativa, investimento nella figura. Come quel famoso “mettiamo la persona al centro” che fino a poco tempo fa non era che una bella frase, ma ora ci siamo resi conto che effettivamente quello che fa la differenza è la persona che abbiamo».
Ultimamente si parla molto di un cambiamento del mercato del lavoro e del modo stesso di percepire il lavoratore, come figura più autonoma e imprenditoriale, anche quando si parla di lavoro dipendente. È questo il trend che emerge dal mercato?
«Certo, al punto che non si parla più, ormai da tempo, di persone che cercano lavoro, ma di figure che valutano altre opportunità. Con un tasso di disoccupazione bassissimo e in continua decrescita, il flusso maggiore è fatto da questa fetta del mercato. L’abbiamo visto l’anno scorso col cosiddetto movimento delle “grandi dimissioni”, questo approccio più dinamico al proprio lavoro, per il quale si passa più facilmente di un tempo da un’azienda all’altra».
Quali sono le soluzioni possibili al mismatch?
«Bisogna dare al mercato del lavoro la stessa attenzione che si dà al mercato cliente: il collaboratore stesso dovrebbe diventare il cliente primario. Questo si traduce in una comunicazione adeguata a livello di employer branding, in un ascolto attivo del collaboratore, per capire perché sta con me e per far convivere il processo di vita che questa persona ha con i processi della mia azienda. Vuol dire, chiaramente, confrontarsi col mercato del lavoro e aggiornare il pacchetto che offro, ma anche avere all’interno le competenze e le conoscenze per poterlo fare. I tempi attuali non permettono di delegare a terzi tutto ciò che concerne il personale: la cultura lavorativa la devo creare all’interno dell’impresa, non posso delegarla. Infine, bisogna avere le competenze. Specie nella traction, cioè quello che devo mettere in atto per essere anche solo conosciuto sul mercato».
In generale, si ha l’impressione che in Italia l’attenzione all’“employer branding” non sia ancora molta. Che cosa stiamo sbagliando?
«Il tema è scottante, perché per ora chi applica questi principi è solo la punta di un iceberg, rappresentata dalle aziende più strutturate o dalle startup. Ma, a parte questi estremi, il tessuto socioeconomico italiano sta soprattutto nel mezzo. È quel 95% di PMI, spesso familiari, che tutto il mondo ci invidia, ma che pongono tutta la loro attenzione nel processo produttivo e nella comunicazione verso il cliente. L’employer branding, invece, non è percepito come un bisogno. Ora che però è diventato necessario le aziende non sanno ancora come approcciarvisi. Per fare un esempio, ormai è il candidato a chiedere perché dovrebbe lavorare in una determinata azienda, non il contrario. E le posso assicurare che la maggior parte delle realtà, anche strutturate, non sanno rispondere, semplicemente perché non si sono mai poste la domanda. Così l’employer branding rischia di rimanere un concetto astratto, non legato ai valori aziendali reali. E si finisce per raccontare qualcosa che, una volta entrati in organico, non risponde alla realtà».
A livello nazionale, cosa si può fare per attrarre più risorse, o almeno per non perdere quelle che già abbiamo?
«Più che un rischio, la fuga di cervelli è già una realtà concreta. Il trend dei giovani che lasciano l’Italia per andare altrove è in netta crescita. Ed è una crescita che è destinata a continuare. Infatti, se andiamo a vedere i tassi di disoccupazione degli altri grandi Paesi europei, vediamo che sono ancora più bassi del nostro. A volte, come per Svizzera e Lussemburgo, perfino sotto il livello fisiologico. Per sopperire, è il Paese stesso a fare recruiting. Il Lussemburgo, ad esempio, ha una strategia nazionale di employer branding. Oppure, in alcune aree della Germania, il land lancia veri e propri pacchetti da offrire alle famiglie che si spostano. Noi questo non l’abbiamo. Se è vero che attualmente non siamo competitivi sugli stipendi, si può migliorare anche su altri fronti. E se vogliamo invertire il trend, per prima cosa bisogna adottare uno story-telling diverso. Dobbiamo raccontare ai giovani con voglia di fare che possono avere dei sogni anche qui».
Qual è il piano su cui c’è più da lavorare, come sistema-Paese?
«Dobbiamo lavorare su tutti i fronti. Attualmente il mercato del lavoro è europeo, non italiano e non locale. Soprattutto le nuove generazioni guardano molto bene cosa fa l’estero e sono disponibili a trasferirsi. Se noi ci focalizziamo su una sola leva restiamo in ritardo su tutte le altre. È fondamentale il discorso economico, ma deve anche cambiare la cultura lavorativa per fare in modo che i ragazzi trovino le possibilità di carriera qui e scoprano i grandissimi vantaggi che le nostre imprese hanno da offrire loro». ©
Articolo tratto dal numero dell’1 febbraio 2023 de il Bollettino. Abbonati!